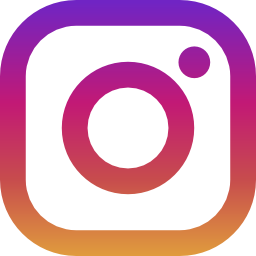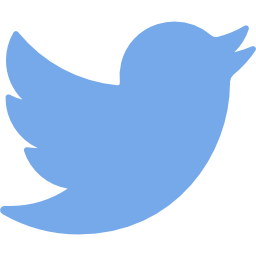Il numero di novembre della Rivista Essere A Scuola interroga il lettore esperto: siete pronti a lasciarvi ispirare e guidare dalla saggezza e dall’esperienza di coloro che hanno dedicato la loro vita a educare menti e cuori?
Condividiamo qui l’editoriale di Pier Cesare Rivoltella, il sommario del terzo numero.
Un discernimento strano
Al terzo anno di università, il nostro professore di Storia della Filosofia contemporanea ci propose un corso monografico dedicato al rapporto tra filosofia analitica e discorso religioso. La filosofia del ’900 aveva tenuto sostanzialmente due posizioni al riguardo.
I neopositivisti – come Schlick e Carnap – avevano chiuso drasticamente la questione: se solo le proposizioni che possono essere verificate, ovvero giudicate vere o false, sono dotate di senso, una proposizio- ne come «Dio esiste», che sfugge a qualsiasi tentativo di verifica, è chiaramente priva di senso. Dall’al- tra parte, Wittgenstein chiude il suo Tractatus Logico-philosphicus, alludendo al problema del Mistico e ammettendo che nulla di ciò che più conta per la nostra vita può essere racchiuso entro i limiti del lin- guaggio della logica e della scienza.I filosofi analitici, che dal pensiero di Wittgenstein prendono spunto, provano a mettere a tema proprio questa “eccedenza” di ciò che ha più senso rispetto alle pretese dimostrative della scienza. Tra questi filosofi c’è Ian Ramsey (1967) che imposta la sua riflessione attorno alla semantica del linguaggio reli- gioso. Per Ramsey il linguaggio religioso trova il proprio significato nel fatto che, dentro il linguaggio ordinario, crea le condizioni per il generarsi di un’“illuminazione”, che richiama l’attenzione del soggetto consentendogli di sviluppare un “discernimento strano” cui subito dopo fa seguito le necessità di assumere un impegno. Insomma, su per giù, dice Ramsey: qualcosa richiama la nostra attenzione, richiamati da questo qualcosa ci accorgiamo di qualcos’altro e proprio in virtù di questo ci sentiamo in- gaggiati a livello di impegno.
Mentre facevo esami, una mattina dello scorso mese di settembre, l’incontro con due dei miei studenti mi ha fatto ricordare questa analisi di Ramsey.
Se una mattina di fine estate un professore
Conoscevo la storia di Enrica (nome di fantasia), studentessa fuori sede con problemi psichiatrici. Ne avevamo parlato anche i con i genitori. Dopo un anno di vacanza dagli studi per potersi curare, era tornata in università, ma nelle sessioni estive l’avevo vista in estrema sofferenza: poco curata, disorientata, disperata. In particolare, l’ultimo colloquio che avevamo avuto era durato quasi un’ora. Più che un esame, una seduta, in cui avevo provato a tranquillizzarla, rassicurarla, contenerla. Una fatica enorme e una pena infinita per lei, per le sue condizioni.
Conoscevo bene anche la storia di Elia, uno studente con la vocazione all’insegnamento e una dislessia severa. L’anno prima si era distinto nel mio corso per l’intelligenza delle domande, delle osservazioni; spesso, arrivando presto in aula tutti e due, ce ne eravamo andati al bar dell’università a prendere un caffè parlando del più e del meno. Mi cerca via mail, mi chiede di potermi vedere. Ha saputo che cambio università e mi confessa che con me se ne va il suo riferimento. Gli dico di raggiungermi in sede d’esame. Mi racconta che le cose non vanno bene. Alcuni corsi gli richiedono un forte esercizio mnemonico, alcune prove valutano proprio quello che lui non riesce a fare. Si sta demotivando, sta pensando di lasciare gli studi, anche perché – mi confessa – si sente isolato dai compagni e dalle compagne di corso.
Non capiscono le sue intenzioni, le ragazze pensano che “ci provi”, lui invece vorrebbe solo un confronto, un supporto. Gli chiedo se abbia provato a parlare con i docenti. E lui mi dice che spesso la risposta è: “Capisco il suo problema, ma le chiedo di fare quello che domando”.
Quella mattina Enrica arriva curata, ben vestita. Ha cambiato colore e taglio di capelli. Sorride, sembra serena. Durante l’esame risponde in modo appropriato, centrata. Le mostro tutta la mia sorpresa e la mia gioia nel trovarla così. Sta meglio, cambierà corso di studi, rientra a casa. Mi ringrazia per averla ascoltata. La saluto a esame finito, assicurandole che mi avrebbe potuto cercare per qualsiasi cosa in qualsiasi momento.A Elia invece ho detto che riflettesse bene per capire dove passasse la linea della sua sopportazione. Sotto quella linea avrebbe avuto senso soffrire per raggiungere il suo obiettivo. Ma sopra quella linea vorrebbe dire chiedere troppo a se stesso: stare troppo male non è sostenibile, per nessuno. Lo incoraggio a pensarci, lo invito a rivederci presto. Riprendo a fare esami. Mentre interrogo, vedo Elia che torna dentro. Porta in mano tre caffè nel bicchierino di carta, con il tappo, lo zucchero, il bastoncino per mescolare. Uno me lo porta in cattedra, gli altri due li lascia alle mie due assistenti che stanno anche loro facendo esami. Ci guardiamo senza dire altro: gli stringo la mano incrociando la sua come per avviare un braccio di ferro, come fanno i ragazzi oggi. Mentre si allontana e riprendo il mio esame mi accorgo che mi sono commosso.
Discernimento strano e presente di incarnazione
Enrica che si siede, quasi irriconoscibile nella sua normalità, e risponde a tono, come Elia che mi porta il caffè in cattedra, “alla nostra maniera”, sono due situazioni di “illuminazione”. Nell’ordinarietà di una sessione d’esame, nell’avvicendarsi degli studenti a colloquio, qualcosa rompe lo schema, richiama l’attenzione, suggerisce che qualcosa sta accadendo o è accaduto. In tutti e due i casi l’esito è un discernimento strano. Ho ripensato in pochi istanti alla mia storia con quei due ragazzi e, come dire, è come se i puntini si fossero uniti, come se avessi capito in quel preciso momento che quel che avevo fatto era quel che andava fatto. L’esito è la consapevolezza di un impegno da prendere: con Enrica, per poterle rispondere anche in futuro se ne avrà bisogno; con Elia, per non smettere di accompagnarlo, di fare strada con lui, di garantirgli un confronto; per ciascuno dei loro compagni e delle loro compagne di cui magari non mi sono accorto e che forse nascondono lo stesso disagio, le stesse richieste.
I direttori didattici della provincia di Firenze, riuniti in Palazzo Vecchio per incontrarlo, nel 1961, chiedono a don Milani come facesse per fare scuola, quale fosse il segreto. E don Milani risponde in maniera analoga a come già aveva fatto altre volte: non come si fa a fare scuola, ma come si deve essere per fare scuola è il vero problema. In questa consapevolezza c’è il senso profondo dell’insegnamento. Per insegnare bisogna esserci. Serve praticare quello che Pennac (2007) ha chiamato presente di incarnazione. Sentirsi convocati, anima e corpo; saper rispondere alla convocazione, subito, senza esitazioni e senza dilazioni. Essere presenti, pienamente presenti, significa spendersi senza risparmiare le proprie energie. Significa amare più i ragazzi che Dio, come don Lorenzo ammette riconoscendo che questo è uno dei suoi peccati più gravi. Solo se si è presenti ci si può accorgere di un’illuminazione; solo se si è presenti si può sviluppare un discernimento strano; solo se si è presenti ne può seguire l’impegno. Impegno per l’altro, sollecitudine per la sua interpellazione che, come dice Buber (1954), non si può far finta di non aver ricevuto.


Per approfondire:
È possibile sottoscrivere l’abbonamento alla rivista per l’a.s. 2023/2024 in versione digitale o cartacea.
Per effettuare l’ordine e avere maggiori informazioni questa è la pagina dedicata: https://www.morcelliana.net/riviste/abbonamenti.