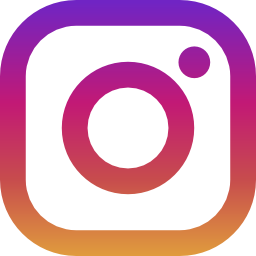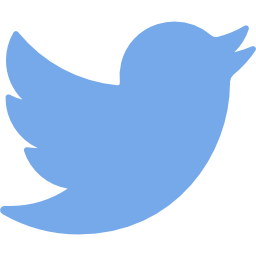Fake News, notizie false. Se ne parla in modo trasversale, dalla scuola alla politica, dalla (falsa) morte di un vip alla diffusione virale di una “notizia” inventata che diventa la motivazione per un attacco islamofobo. L’affermazione in Brasile del neopresidente Jair Bolsonaro si spiega per alcuni critici anche con il ruolo svolto, nella formazione dell’opinione pubblica, da WhatsApp, in un paese in cui il 66% dei cittadini si informa con i social media (è il dato più alto al mondo per il Digital News Report 2018 del Reuters Institute di Oxford); molte di quelle notizie, diffuse tramite liste del servizio di instant messaging, erano fake, seppur sia ancora aperto il dibattito sulla loro reale influenza ( uno studio dell’ITS Rio prova a fare il punto). Invece a Pioltello, provincia di Milano, un bar gestito da un cittadino marocchino è stato incendiato nel maggio 2017 per il presunto festeggiamento dell’attentato islamista al concerto di Arianna Grande a Manchester. Tutto completamente inventato, ma la falsa notizia nasce da un rimpallo tra segnalazioni via social e programmi televisivi. Un “non fatto” che, però, per le emozioni che provoca sui media finisce per diventare vero (è questa la post-verità) e provocare il “realissimo” raid razzista (Valigia Blu, testata che fa del fact checking la sua linea editoriale, ricostruisce qui l’episodio). Infine, uno studio dell’History Education Group dell’Università di Stanford del 2016 sostiene che la maggior parte dei ragazzi americani di scuola media non sa riconoscere una notizia vera da una falsa: l’82% non riconosce un’inserzione pubblicitaria nemmeno quando è presente la dicitura “contenuto sponsorizzato”, oppure (qui il campione diventano i giovani delle superiori) basta associare il logo di Facebook o di un social network a un fotomontaggio per garantire la veridicità di un’immagine assurda.
Tutto ciò non è (del tutto) una novità. La storia del giornalismo è anche storia di bufale e di tensione tra verità e informazione, i media hanno da sempre fatto i conti con le pressioni del potere e con la loro capacità di manipolazione.
Eppure, ora, la questione si complica (spesso collegata alla polarizzazione delle opinioni), poiché con il Web 2.0 sono di fatto richieste ai singoli utenti le competenze professionali tipiche del giornalista, come la selezione delle fonti e il riconoscimento dei canoni di autorialità. Cambia infatti chi riconosce l’autorevolezza della fonte; nella cultura del testo stampato era garantita da poteri centralizzati riconosciuti, seppur orientabili e portatori d’interessi (case editrici, università, quotidiani e riviste), mentre nell’ambiente digitale l’autorevolezza è riconosciuta nei pari. Nei social network si fa continua esperienza dell’essere posti di fronte al dubbio se credere senza evidenze: si deve decidere se ritenere affidabile qualcuno, accreditandolo.
Perché il New York Times è più affidabile del sito xenofobo Tutti I Crimini degli Immigrati? Perché un video negazionista, seppur sia fra i più visualizzati su YouTube e tra i primi indicati da Google quando si cercano contenuti relativi l’Olocausto, non è autorevole riguardo alla Shoah? Sembrano domande scontate, ma non lo sono. Nella ricerca alla base del libro che ho appena pubblicato per Scholé-Morcelliana (“Razzismi 2.0. Analisi socio-educativa dell’odio online, trovate una recensione qui), ho chattato a lungo con giovanissimi autori di performances razziste: quando ho fatto notare a un ragazzo che postava articoli xenofobi che contenevano dati facilmente confutabili attraverso il link al Ministero degli Interni, ha risposto: «Continua a credere ai tuoi amici». Il diciottenne L.M. mi ha spiegato invece come ha aderito a un’ideologia che teorizza l’odio razziale: «Io non ho letto nessun libro, basta informarsi su Facebook, ci sono molte pagine».
Ecco che allora ha ragione il Ministero dell’Istruzione a guardare all’educazione all’informazione come sfida educativa. Il Curriculum di Educazione Civica Digitale del gennaio 2018 invita a sviluppare spirito critico, consapevolezza e responsabilità negli studenti (con Morin potremmo dire “teste ben fatte”) e inserisce, nelle competenze di base, la capacità di cercare, decodificare e utilizzare consapevolmente e criticamente l’informazione. Nel Web 2.0 occorre sviluppare la capacità di valutare provenienza, qualità e credibilità delle fonti informative, e di giudicare la qualità e la completezza delle informazioni raccolte, anche a partire dalle dinamiche utilizzate dai motori di ricerca e da repertori di risorse. Altra competenza riguarda la consapevolezza dei principi normativi, incluse le ragioni alla base dell’accesso e del riuso dell’informazione.
Nell’epoca della post-verità, i contesti educativi possono così vivere la loro funzione di comunità di pratica: è necessario sviluppare il pensiero critico degli alunni; in particolare, ad esempio attraverso la discussione di un dilemma, occorre chiedere di rendersi conto della complessità di un problema; analizzare attori e comportamenti; apprendere a fare delle scelte, esprimere giudizi e chiarire i valori che li sottendono; sviluppare la capacità di fare ipotesi e anticipare le conseguenze delle azioni; esplicitare e argomentare i propri punti di vista; ascoltare gli altri e far evolvere il proprio punto di vista nella discussione. Si vive così una forma di sviluppo morale all’interno di una comunità di ricerca e di educazione al pensiero critico.
Oggi però questo non è più sufficiente perché rappresenta solo la metà dell’opera. Non basta più educare lo spettatore, occorre anche educare il produttore che ogni spettatore è diventato grazie allo smartphone che porta in tasca. Questo significa che insieme al pensiero critico occorre sviluppare anche la responsabilità, ovvero riflettere – anche nel campo dell’informazione non professionista – sulle conseguenze delle proprie azioni. Che poi significa smentire, ancora una volta, la neuromitologia dei “nativi digitali”, ma al contrario ricordarci che dobbiamo tutti tendere a divenire cittadini digitali, in un processo di formazione continua che interpreta la selezione delle fonti come una competenza digitale (e democratica) tutt’altro che innata.
di Stefano Pasta

![[fraME] Fake news. Non basta più educare lo spettatore, occorre educare il produttore che ciascuno è diventato](https://www.cremit.it/wp-content/uploads/2019/01/fake-news.jpg)